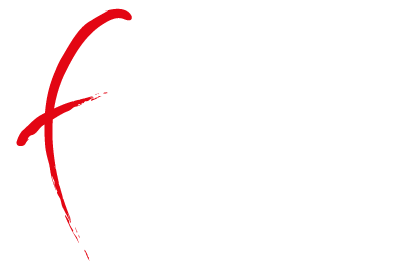“Ai miei tempi era tutto diverso” amava spesso dire mio nonno, quando da ragazzino lo andavo a trovare e quando poi, immancabilmente, dopo aver affermato questo partiva “a nastro” a raccontare le sue storie, che io, ovviamente, mi ascoltavo ogni volta con estrema attenzione.
Ha fatto così fino a poco tempo fa, mio nonno, anche lui aveva capito che il mio lavoro di fotografo si era adeguato ai tempi (sapete vero la storia della pellicola e del digitale…) e che per molti era stato un trauma e motivo di lotta contro i mulini a vento per cercare di evitare l’inevitabile.
Prosaicamente mi disse: “bello il passato, però se quella è la strada del futuro per il tuo lavoro non ha senso non seguirla”. Forte mio nonno, sempre “sul pezzo”, come si dice in gergo giornalistico: parole crociate a go-go e quotidiano fresco tutti i giorni.
Non voglio però parlavi di mio nonno e della sua filosofia, ma mi piaceva l’idea di iniziare questo post con il suo pensiero, “ai miei tempi era tutto diverso…”, perché qualche tempo fa Neil Burgess (ex manager dell’agenzia Magnum) ha dichiarato: “il fotogiornalismo è morto. Nessuna organizzazione o testata editoriale oggi destina più risorse economiche alla produzione di grandi reportage, i fotoreporter oggi ricevono gli incarichi al solo scopo d’illustrare gli articoli e quindi bisogna dichiarare morta la categoria”.
Onestamente non penso proprio che il fotogiornalismo e che la figura del fotoreporter siano defunti. O meglio, è vero che l’editoria destina sempre meno risorse a questo tipo di committenza, ma dall’affermare questo a dire che c’è “scappato il morto” il passo mi sembra un po’ lungo.
Cambiato si, ma morto proprio no; soprattutto è cambiato non tanto il modo di lavorare, quanto le vie di divulgazione e di finanziamento. Provo a spiegarmi meglio.
Si tende a identificare l’epoca d’oro del reportage con gli anni ’30 del secolo scorso quando, ad esempio, i fotografi della F.S.A. (Farm Security Administration) – parlo di Dorothea Lange, Walker Evans, Gordon Parks & Co. – realizzarono eccezionali documentazioni sui devastanti effetti della Grande Depressione del ’29, oppure quando, intorno agli anni ’40, riviste come “Life”, “Time” o “Picture Post” pubblicavano i reportage di Margaret Bourke-White, Robert Capa o Eugene Smith; il tutto, in entrambi i casi, con grandi sforzi organizzativi ed economici. Ecco… quello era possibile anche perché il lettore aveva fame di vedere e conoscere.
Succede però che qualcuno, già negli anni ’50, incolpando in quel caso la repentina diffusione del televisore, definisce il fotogiornalismo morto e sepolto. Era John Szarkowski (non proprio una persona qualunque: fotografo, storico dell’arte e attenzione attenzione, successore di Edward Steichen alla guida della sezione di fotografia del M.O.M.A di New York dal ’62).
Da quel momento la colpa della fine del fotogiornalismo è stata attribuita praticamente a tutto: scarsa attenzione da parte del lettore, pseudo-problemi etici degli inserzionisti pubblicitari a vedere pubblicate le loro campagne di fianco a soggetti piuttosto “difficili”, perdita del senso di compassione e non ultimo (soprattutto dopo l’avvento dell’era digitale) l’invio e la pubblicazione d’immagini di scarsa qualità prodotte da fotoamatori dilettanti, eccetera.
A questo punto della storia va detto però (come già avrete capito da soli) che dagli anni ’30 a oggi il panorama di diffusione mediatica è moooolto cambiato e di conseguenza è altrettanto cambiato il modo di narrare per immagini; ma non è sicuramente morto. “Paris Match”, “Geo”, il già citato “Time” e “Der Spigel” sono oggi tra le poche riviste che ancora commissionano reportage originali; ma esistono anche molti altri nuovi modi di distribuire il fotogiornalismo: riviste e siti specializzati, musei, gallerie e fondazioni perseguono filantropicamente la raccolta, l’acquisto e la produzione fotogionalistica, lo stesso fanno sempre più spesso le grandi ONLUS internzionali.
Sicuramente farne un’attività redditizia da parte dei fotografi, oggi, è sempre più complesso, ma anche qui stanno emergendo, soprattutto grazie al web, nuovi modelli di finanziamento. Quello più interessante è sicuramente il “crowd funding” (letteralmente significa “folla di finanziatori” è però da leggere come “trovare finanziatori in mezzo a una moltitudine di persone”).
Il crowd funding è un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizzano il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni. È un processo di finanziamento dal basso che mobilita persone e risorse. Il termine nasce dal “crowdsourcing”, il processo di sviluppo collettivo di un prodotto. Il crowdfunding si può riferire a processi di qualsiasi genere, dall’aiuto in occasione di tragedie umanitarie, al sostegno all’arte, fino all’imprenditoria innovativa e alla ricerca scientifica. O perché no anche alla politica: vedi la campagna di Barack Obama. Come avete ben capito questo sistema non nasce nella fotografia ma sta trovando in essa una nicchia molto interessante e interessata: per certi versi potrebbe essere il canale giusto per quel fotogiornalismo che in molti danno già per sepolto.
Con questo sistema, che si sviluppa soprattutto grazie al web e soprattutto grazie a siti specializzati, il fotografo può presentare il proprio progetto direttamente a un pubblico attento che decide quali progetti sostenere, seguendo la propria sensibilità o i propri interessi. E lo fa attraverso la donazione on-line.
Il sistema sta avendo un notevole successo: ciò dimostra che c’è ancora un “grosso” pubblico interessato al fotogiornalismo (quello serio) e dimostra anche che questo pubblico è potenzialmente disposto a contribuire per alimentare il proprio interesse.
Forse mio nonno aveva ragione: “se il futuro è quello, che senso avrebbe non percorrerlo”.
Se volete partecipare a qualche progetto fotografico in crowdfunding il sito che offre le proposte più interessanti è senza dubbio www.emphas.is
 English
English  Italiano
Italiano