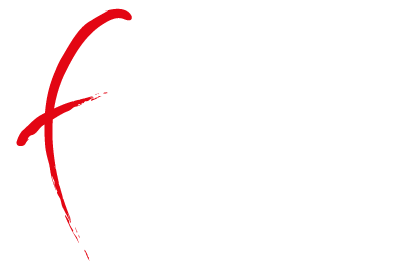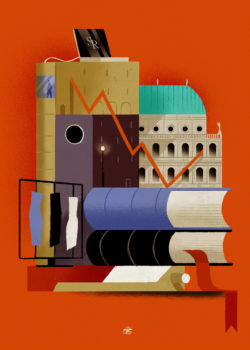Ken Russell non è mai stato uno di quei registi particolarmente amati dalla critica. Quando scrivevano dei suoi film, molto spesso venivano usati termini come “delirante”, “folle”, “orgiastico”, “eccessivo” e via di seguito, indipendentemente dal valore più o meno alto della pellicola.
Ricordo che una sera, anzi una notte, a Fuori Orario Enrico Ghezzi presentò Tommy definendolo una specie di esempio di “brutto cinema inglese”. Ovviamente l’eloquio del Ghezzi è sempre suscettibile di libere interpretazioni, anche le più varie, sta di fatto però che comunque espresse l’opinione corrente degli acculturati addetti ai lavori. Cioè che Ken Russell era interessante e andava tenuto d’occhio, però con molte riserve.
Non fu mai molto amato neppure dal pubblico, se si escludono alcuni successi come il già citato Tommy, I diavoli e Stati di allucinazione. Però si trattava sempre di una popolarità derivata più che altro dalla fanfara pubblicitaria che strombazzava massicciamente sull’alone scandalistico ormai divenuto parte posticcia e fuorviante di ogni uscita del regista di Southampton.
Un film come I diavoli veniva fruito in Italia con la stessa curiosità piccolo borghese con cui veniva assimilato a uno dei tanti prodotti di bassa lega soft-core sui turbamenti di giovani monache in estro, all’epoca molto in voga. Più o meno la stessa sorte che toccava ai film di Pasolini.
Ma bando a queste tristezze e torniamo al “brutto cinema inglese” di Ken Russell per ciò che il regista desiderava che fosse realmente, cioè alle caratteristiche peculiari e reali della sua opera.
Una era proprio che fosse inglese. Non si scappa, Russell ex pilota della RAF, amava con ogni evidenza la sua terra e lo dimostrava in ogni occasione. A cominciare dal primo film Il cervello da un miliardo di dollari, tipica spy story molto british, col più british degli attori: Michael Caine; poi Donne in amore e La vita è un arcobaleno da opere di D. H. Lawrence; I diavoli e Stati di allucinazione, direttamente e indirettamente da Aldous Huxley (mi perdoni Paddy Chayefsky); L’ultima Salomè da Oscar Wilde; Gothic con protagonisti i poeti romantici Byron e Shelley; La tana del serpente bianco, che ha come tema una leggenda locale; e Tommy, opera rock scritta da un gruppo molto inglese e che “suonava” in inglese, gli Who, con personaggi di contorno tutti molto britannici, a cominciare dalle infermiere del reparto maternità, con quella divisa che caratterizzava solo le infermiere d’oltremanica (fateci caso, se in un film c’è un’ambientazione ospedaliera, il film inglese si rivela subito per via di come sono vestite le infermiere).
Un altro elemento che vale la pena sottolineare in Ken Russell è la costante presenza dell’erotismo. Attenzione però, non sto parlando della sessualità grassoccia ed edonistica spacciata fin dagli anni’60 come fonte di ogni libertà e gioia, ma di erotismo in senso batailliano, baudelairiano, sofferto e strettamente imparentato al dolore e al dissolvimento della coscienza.
In altre parole erotismo come esperienza mistica. E questo nei film di Ken Russell c’è. Non solo c’è, ma c’è in forma urlata. Non si può neppure parlare di simboli. È tutto evidente. Nei falli finti, nell’abbigliamento femminile con gli innumerevoli reggicalze (perfino in Lisztomania, biografia di Liszt e in Perdizione, biografia di Mahler), nel rifiuto dell’arte come rappresentazione di “corpi senza buchi” (come afferma il protagonista di Messia selvaggio), nell’omosessualità di Donne in amore e di L’altra faccia dell’amore (biografia di Tchaikovsky); e poi donne mantidi, stivali, tacchi, fruste, il dolore continuo di Whore, una specie di inferno in terra e la religione mescolata a istanze sadiane come ne I diavoli.
E non è tutto. Che senso può aver avuto definire con poca fantasia e molta banalità “delirante” un’opera molto spesso ispirata alla psichedelia? Ho già detto che Ken Russell ha avuto tra i suoi ispiratori Aldous Huxley; l’Huxley di Le porte della percezione a sua volta ispiratosi a William Blake (toh, un altro inglese e per giunta anch’egli “delirante”).
In realtà si trattava non di delirio, ma semplicemente di uno stile psichedelico: e questo in genere si compone di elementi disparati e molto colorati fin dai tempi dei Beatles. Una sorta di camp che appariva però ostico, per il gioco continuo di accumulo anche di sfacciati elementi kitsch e per la sua volontà di non essere tranquillizzante o beatamente onirico.
Ken Russell era scomodo. La sua follia era tutta qui.
 English
English  Italiano
Italiano