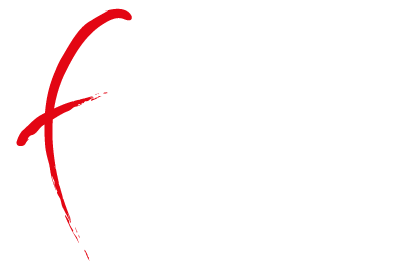Il Natale cominciava per Santa Lucia, quando cadeva la prima neve. C’erano da fare un sacco di cose: raccogliere il muschio per il presepe lungo la strada che porta alla scuola, trovare un alberello in pineta, procurarsi qualche rametto di vischio nei boschi di querce, preparare l’impasto delle spongate, scrivere i biglietti e le cartoline ai parenti. Eravamo tutti presi da una febbre leggera e piacevole. Fino alla gran cena della Vigilia. Una cena di magro, ma da leccarsi i baffi. Si partiva con la zuppa di funghi, che poteva essere cucinata solo una volta all’anno, quella sera. Si metteva in un grosso tegame di porcellana bianca uno strato di pane secco, rigorosamente fatto in casa, uno strato di porcini essiccati e soffritto, un altro strato di pane; soffritto, ancora pane, funghi e formaggio grattugiato. Il tegame doveva stare un’oretta nel forno a bassa temperatura, fino a che il primo strato non diventava croccante. Il profumo dei porcini arrivava in tutte le stanze della casa; forse anche Arco lo sentiva nella sua cuccia in cortile.
Sotto le gaggie, due piante alte più di venti metri spalleggiate da un ippocastano gigante, c’era una tavolata sterminata, tutta all’ombra: dalle chiome verdi non filtrava un raggio di sole. Gli zii e le zie di mio padre al gran completo e i miei zii, erano seduti lì col vestito della festa. Si godevano il profumo di salvia e rosmarino che arrivava dai cespugli vicini. Il menù della sagra si ripeteva sempre uguale. Sottoli e sottaceti fatti in casa (Si Morèt non avrebbe mai mangiato «quella roba in scatola») con salame nostrano e prosciutto stagionato due anni. Una fondina fumante con trenta cappelletti galleggianti in brodo misto di manzo, cappone, maiale e gallina. Un piatto con venti tortelli d’erbetta appoggiati su un letto di burro fuso e coperti da una nevicata di parmigiano reggiano di tre anni. Cacciatora di coniglio secondo la ricetta di nonna Marianna, arricchita dalle modifiche, preziose, di mia madre. Pollo al limone in casseruola. Zuppa inglese. Dolce amore. Angurie di Santa Vittoria fresche di pozzo. E, per digerire, grappa fatta in casa o nocino. Sotto i tavoli, decine di bottiglie un tempo piene di vino rosso di Casatico.
Alle sette di sera, Sì Morèt si alzava da tavola e diceva «Basta ragass, a son pjin». Allora Fortunato tirava fuori la fisarmonica e tutti andavano a ballare sull’aia di mattoni. Polke, valzer e mazurke. Come in un film di Fellini. Dopo la mezzanotte la Pallas di Tonino arrivava nel cortile: «Papà vieni con me in macchina?». «Io e la Polda torniamo a piedi. Dobbiamo digerire».
Da Il sole e la neve di Luigi Alfieri
 English
English  Italiano
Italiano