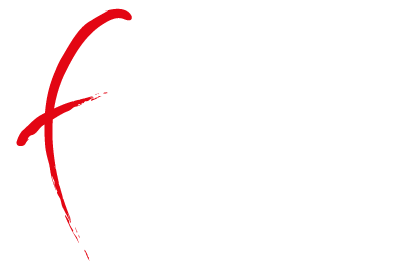In posa, intenti a osservare da un microscopio o da un binocolo, oppure a scrutare gli antichi segni di una carta geografica alla ricerca di un mondo inesplorato o di un paesaggio, di una natura incontaminata. Gli adulti e i bambini protagonisti della serie Sottovetro di Silvia Noferi – in queste settimane in mostra a Reggio Emilia, presso la Vetrina di CSArt – “tracciano con la loro coreografia muta una fenomenologia minima dello sguardo”, come scrive l’artista stessa, e segnano una distanza tra l’uomo e il paesaggio, e tra le stesse persone, con le loro difficoltà a comunicare. Sottovetro, come nelle vetrine di un museo, dove la logica è quella del “guardare e non toccare” e l’intento è quello della conservazione, della tutela; ma le fotografie che ne scaturiscono risultano pervase da un’atmosfera ambigua: chi osserva è esso stesso osservato e il confine fra quel che c’è sotto il vetro e quello che sta fuori è labile e mutevole.
Ripercorrendo i vari progetti della fotografa fiorentina, classe 1977, quello che emerge con decisione è un senso di straniamento che percorre gli scatti: sospese in un silenzio ovattato che permea anche un cromatismo dai toni poco saturi e pastellati, le immagini sono spesso composte sotto forma di dittici e trittici di medio e grande formato, come nel caso di Notturni. Anche qui torna il tema del dialogo tra il “dentro” e il “fuori”, dove nel primo si scorgono solo i corpi di persone addormentate ritratte nella loro intimità fragile, delle quali non è mai visibile il volto, e nel fuori paesaggi urbani e naturali immobili e deserti, in cui la vita sembra sospesa e rarefatta. Analoga sensazione può dare Playground, una riflessione condotta attraverso la tecnica del foro stenopeico in cui, attraverso le lunghe esposizioni e l’uso dell’autoritratto, il percorso è tra un prima – l’infanzia – e un dopo – l’oggi.
Tutta la ricerca di Silvia Noferi, spesso influenzata dalla filosofia, si caratterizza per una valenza evocativa che tocca da vicino l’immaginazione, il sogno, la pratica del fantasticare e dell’immaginare senza mostrare; una poetica che ben si sposa con la costruzione di veri e propri set cinematografici, di scenografie eleganti e raffinate dove si collocano, come presenze distanti e isolate, le figure umane ed animali (ad esempio nel caso di Angelina e il cane). In Hotel rêverie è esplicita la decontestualizzazione dei gesti dei soggetti rispetto agli ambienti – suggestivi e decadenti – antichi, ricoperti di sgargianti carte da parati e connotati da rari oggetti dall’innegabile significato simbolico.
E portante è sempre il tema del guardare qualcosa che non si vede, un fuori campo che forse è il reale punto focale delle fotografie dell’artista che preferisce lasciare allo spettatore il compito di completare l’immagine, incaricandolo di sciogliere il dubbio e di compiere una scelta personale, carica di responsabilità.
 English
English  Italiano
Italiano