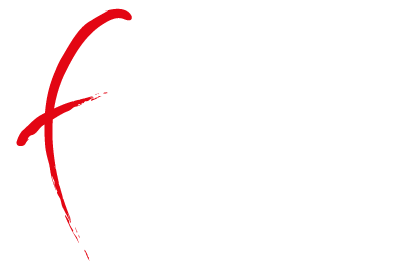“Quando si cerca in uno spazio, di fotografare un soggetto e il sogetto è lo spazio stesso, succede che uno si sposta guarda, lontano, vicino e fa dei movimenti strani è come se facesse una danza, mette in atto un sorta di gestualità come quella di un rabdomante che va in cerca di qualcosa che non si vede; perché la fotografia è così, fin che non c’è non si vede”
Per raccontare l’opera di un personaggio come Gabriele Basilico, tralasciando il percorso che l’ha portato alla fotografia, considero fondamentale iniziare da un luogo in particolare e in un preciso momento storico: 1968/69, Milano, Galleria Diaframma. E’ qui che Basilico conosce, stringendo con lui un forte legame professionale e di amicizia, Gianni Berengo Gardin; punto fondamentale di riferimento per Basilico, e anche colui che lo spinge a fare della fotografia la propria vita.
Il cambiamento professionale arriva quando nel ‘78 inizia a realizzare la sua prima vera indagine sul paesaggio urbano; in quel momento capisce di aver già sviluppato inconsciamente una particolare attitudine alla “fotografia contemplativa”, quella che permette di osservare un luogo o un paesaggio interiorizzandolo e cercando poi di farlo aderire il più possibile alla “tua” realtà percettiva – quindi non il guardare veloce del fotografo che cattura una scena che vede, bensì il restare in un posto e cogliere qualcosa “di più” .
Questo percorso negli anni successivi è stato sviluppato e perfezionato sempre di più, fino alla sublimazione assoluta e anche oltre, compiutasi con altri due eccezionali documenti: il primo arriva poco tempo dopo la ricerca industriale milanese, ed è l’inserimento nel progetto della Mission photographique de la DATAR sulla trasformazione del paesaggio urbano della Francia; il secondo, e stato dell’arte assoluta (a mio giudizio personale) del lavoro di Basilico è il progetto sulla rinascita di Beirut alla fine della guerra: dove capisce, con non poche difficoltà legate anche a un suo aspetto etico, che quello a cui si trova fronte non è una distruzione totale, ma una distruzione di “pelle”; come se la città di fronte ai suoi occhi fosse stata aggredita da una malattia della pelle, una malattia che l’ha completamente scarificata lasciandone però intatta l’ossatura.
Come un rabdomante e senza farsi minimamente influenzare dal dramma della guerra, ritrae la città come se fosse viva, come fosse un’architettura nella quale era completamente visibile la struttura fisica e la sua distruzione. Va a cercare il senso di vuoto per concentrarsi sullo spazio, per farlo diventare attore principale della scena, e questo lo aiuta a mettere in mostra una città che nonostante il dramma sempre visibile ha ancora la sua sempre forte e chiara identità nonostante le profonde ferite. In quel contesto lo spazio raccontava, in più, un pezzo di storia.
In memoria di Gabriele Basilico (1944 – 14 febbraio 2013), ispiratore del mio Brownfield.
 English
English  Italiano
Italiano